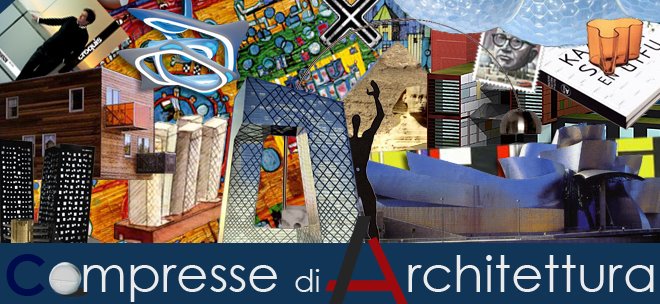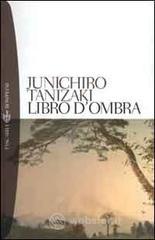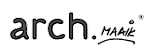E' con questa frase che Juhani Uolevi Pallasmaa (14.09.'36, Hameenlinna, Finlandia), autorevole architetto, un tempo professore di Architettura all' Helsinki University of Technology e Direttore del Museum of Finnish Architecture, ha intitolato il suo manoscritto (The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses), pubblicato per la prima volta in Italia da Jacabook nel maggio 2007.
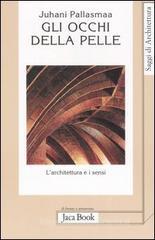
Nella parte prima di questo libercolo protagonista è la Vista, il cui primato indiscusso in Occidente è riscontrabile già nel pensiero degli antichi Greci.

Platone considerava la vista il dono più grande dell'umanità, e sosteneva che gli universali etici dovessero essere accessibili all' 'occhio della mente'.
Forse non è dunque un caso che 'il luogo della Vergine', il Partenone, richiami alla mente sia l'ideale di democrazia ateniese, sia una delle più splendide espressioni degli ideali architettonici di chiarezza e unità.
In seguito filosofi, studiosi, architetti non mancarono di adoperare metafore oculari, a tal punto che si giunse ad intendere la luce come metafora della verità.

Un esempio lampante di ciò credo che possano essere considerate le architetture di culto ove la luce penetra prepotentemente suggerendo al fedele la verità divina, illuminandolo, appunto.
Nel Rinascimento venne elaborato un sistema gerarchico, che vide primeggiare, ancora una volta, la vista.

La vista era collegata al fuoco e alla luce, l'udito all'aria, l'olfatto al vapore, il gusto all'acqua, e il tatto alla terra.
Con l'invenzione della prospettiva il ruolo predominante dell'occhio venne ancor più rinvigorito: esso divenne il punto centrale del mondo percettivo e del concetto di sè.
'La pittura sarà addunque non altro che intersegazione della pirramide visiva, sicondo data distanza, posto il centro e costituiti i lumi', con questa frase l'Alberti incentrò la riflessione dell'architettura occidentale su questioni di percezione visiva.
Possiamo quindi considerare che da prim-ceps dei sensi, la vista, ne divenne l'oppressore.
Molteplici filosofi scrissero così di paradigma oculocentrico, di oculocentrismo, del codice culturale oculocentrico e ossessivamente igienico.
Questa tirannia della Vista è riscontrabile persino se si volge lo sguardo al periodo dei modernisti.
Corbù, fortemente influenzato dalla visita al Partenone durante il suo Voyage d'Orient, elaborò il concetto secondo il quale l'architettura fosse fondamentalmente un'arte di volumi geometrici o il 'magistrale, esatto, magnifico gioco di volumi portati insieme alla luce'.

Le Corbusier, La mensola del camino, 1918, cm 58,5x48. Quello che Le Corbusier spesso indicava come 'il suo primo dipinto' fu anche da lui spiegato quale raffigurazione astratta delle sue due settimane sull'Acropoli - un paesaggio montano codificato come un' ombrae un cubo di legno come Partenone.
In un periodo, sottoposto ad 'una pioggia ininterrotta di immagini', come scrisse Calvino, si giunge così alla 'perdita di profondità esperienziale' (D.Harvey, La crisi della modernità).
Così Pallasmaa denuncia: 'l'architettura è diventata una forma d'arte a rischio', ridottasi ad 'un apparato scenico per l'occhio, una scenografia priva di autenticità materiale e costruttiva'.
Esortando così gli architetti di tutto il mondo al tentativo di ri-sensualizzare l'architettura, l'autore conclude la prima parte del libro elencando i punti fondamentali attraverso quali agire:
il rafforzamento del senso di materialità e tattilità, orditura e peso, densità di spazio e luce materializzata.
-to be continued-
P.S.
Per quanto riguarda il concetto di 'oculocentrismo ossessivamente igienico' mi sentirei di consigliare la lettura di Junichiro Tanizaki, Libro d'ombra, Bompiani.